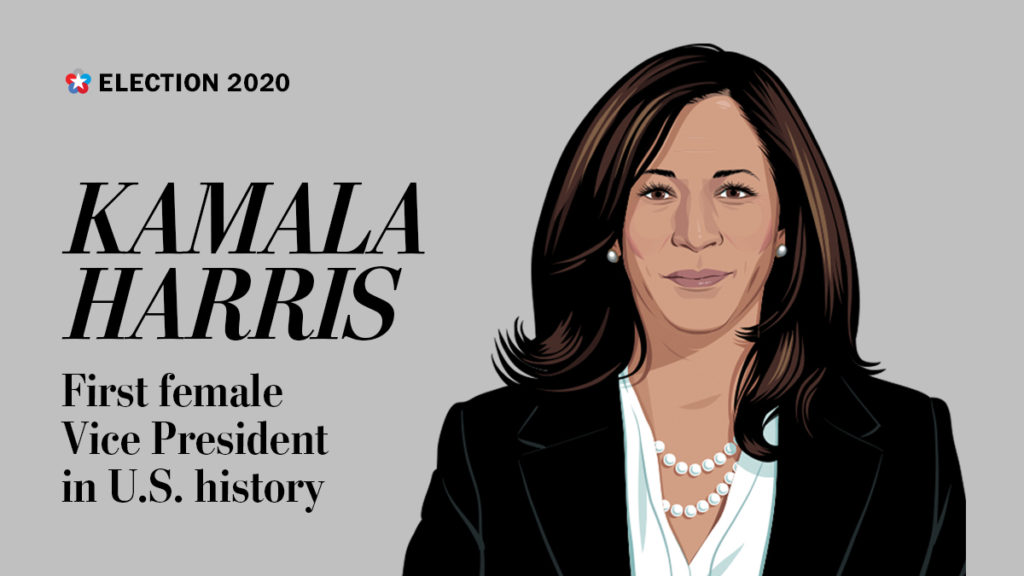
Kamala Harris, raggiungendo la vice-presidenza degli Stati Uniti, come vice di Joe Biden, frantuma non uno ma ben tre tetti di cristallo. Quello di genere innanzitutto, quello razziale e quello migratorio. La rilevanza storica di questo risultato della senatrice californiana, è comparabile con quella che 12 anni fa portò alla candidatura e alla vittoria di Barack Obama. Prima di lei solo tre donne erano state candidate. Alla vice-presidenza Geraldine Ferraro nel 1984 in ticket con Walter Mondale contro Ronald Reagan; Sarah Palin con John McCain contro Barack Obama; Hillary Clinton alla presidenza contro Trump; sono state le uniche tre donne a contendere la Casa Bianca, finendo sempre sconfitte. In un’epoca storica votata al pessimismo, in particolare per le istanze di progresso e uguaglianza, invece Kamala Harris rappresenta un passo straordinario nella caduta del plurisecolare dominio del maschio bianco sul pianeta, così plasticamente incarnato da Donald Trump e della riproposizione della necessità di ridurre le disuguaglianze, che questa è stata capace di colmare da outsider assoluta.
Negare che Kamala Harris incarni molti gap superati è infatti un esercizio di cecità e di stupidità per una donna che è riuscita a diventare una dei due senatori della California, il più popoloso stato degli USA, con i suoi 40 milioni di abitanti, e con un PIL maggiore di quello della Gran Bretagna. Partiamo da un dato incontrovertibile. Nella storia degli Stati Uniti, i senatori afro-discendenti sono stati appena dieci, due nel XIX secolo, due nel XX secolo, sei nel XXI secolo, Harris compresa, che è appena la seconda donna afrodiscendente senatrice nella storia. Appena otto sono di origine asiatica (e qui Kamala è di nuovo calcolata). A questi aggiungiamo nove ispanici e tre nativi. In quasi 250 anni di storia degli Stati Uniti appena 29 sono stati i membri del Senato non bianchi. Le donne non bianche poi, non arrivano alle dita di una mano.
Dunque una donna, figlia di immigrati non bianchi provenienti dalla Giamaica e dall’India arriva alla Casa Bianca, mettendo in un colpo solo in discussione il gender gap, quello razziale e quello migratorio, e questa non sarebbe una cosa straordinaria? Non basta, per alcuni non basta mai. Ad alcuni pare perfino che i suoi natali non siano abbastanza disgraziati per considerarla meritevole. In particolare, il fatto che i genitori di Kamala Harris siano entrambi giunti negli USA per studiare, abbiano poi avuto una buona carriera accademica, economista il padre, medico la madre, impedirebbe di considerare la Harris una “vera immigrata” ma piuttosto un’esponente della classe dirigente, quasi un membro aggiunto della aristocrazia americana. Laddove non si può stigmatizzare l’alterigia di Hillary Clinton, se ne costruisce una ad arte; va da sé, falsa. Da agosto in qua ho trovato questo aspetto sottolineato soprattutto in lingua italiana, in un paese dove è invalso lo stereotipo per il quale “immigrato” sia sinonimo da destra di indesiderabile, e da sinistra di “ultimo” da compatire per le sue disgrazie, e non di persona in cerca del suo posto nel mondo in grado di apportare almeno quanto riceve dal paese di arrivo. Kamala Harris, donna in carriera (e che carriera!), figlia di immigrati di classe media, non sarebbe una vera immigrata perché romperebbe lo stereotipo di dannata della terra e sarebbe pertanto da rubricare come privilegiata (sic).
Descrivere la famiglia di Kamala Harris come appartenente a una élite facoltosa e quindi sostenere che l’appartenenza di classe cancelli in un colpo solo discriminazione di genere, razziale e migrazione (e quindi l’importante ascesa intergenerazionale degli Harris Gopalan) è innanzitutto falso: un docente universitario in posizione apicale ha un buon reddito ma non è né ricco né classe dirigente. Se proveniente dal Sud del mondo poi, non porta con sé alcuna accumulazione primaria che non la faccia cominciare da zero.
Per pagare gli studi in California di Shyamala Gopalan, la madre di Kamala Harris, scomparsa nel 2009, suo padre, il nonno, che era un funzionario pubblico indiano che partendo da stenografo arrivò a un buon livello, impegnò la propria liquidazione. Shyamala lo ripagò in modo brillante, divenendo la prima Gopalan laureata, riuscendo a entrare in un PhD e poi avendo una carriera accademica in un mondo dove era una totale outsider.
Appena arrivata negli Stati Uniti, Shyamala studiava e marciava per i diritti civili. E così conobbe colui che sposò negli anni Sessanta (divorziando nel ’71), Donald Harris. Questo veniva dalla stessa “parrocchia” di Bob Marley, in Giamaica. La sua famiglia, fino a poche generazioni prima, era di proprietà di Hamilton Brown, un irlandese e il più grande proprietario di schiavi dell’isola. Gli Harris non erano abbastanza poveri da non potersi permettere di far studiare Donald. Questo, militante di sinistra da sempre, li ricompensò costruendo una carriera accademica di prestigio da economista keynesiano in un mondo dove già andavano avanti solo i neoclassici.
Coerente con la propria storia, Donald Harris ha dedicato la sua vita di studioso alle disuguaglianze e al sottosviluppo, in particolare in Giamaica. Furono i movimenti per i diritti civili che fecero innamorare quel giovane accademico venuto da un’isola dei Caraibi e la dottoranda venuta dall’India. Furono i libri, non i soldi che, in una famiglia di immigrati, abbastanza bravi a scuola da vincere borse di studio e non rinnegare se stessi, hanno creato le basi per permettere a Kamala Harris di proseguire quella straordinaria ascensione intergenerazionale che oggi la porta addirittura alla Casa Bianca. Brava, gigantesca Kamala Harris.
 Gennaro Carotenuto
Gennaro Carotenuto